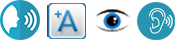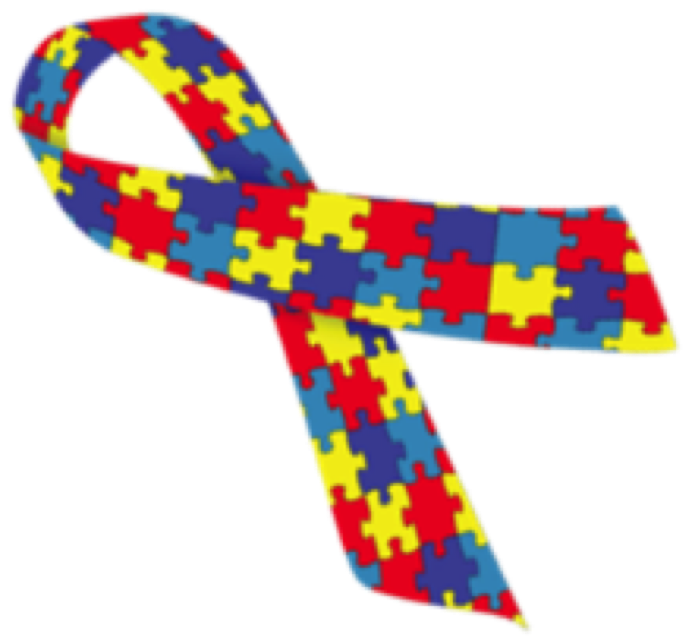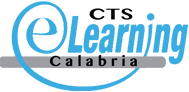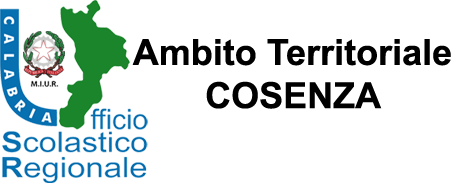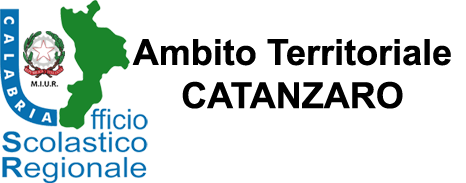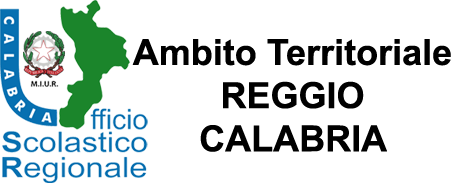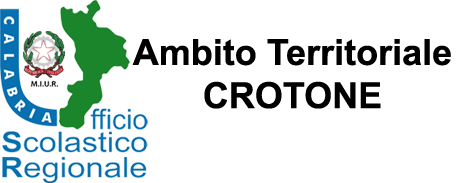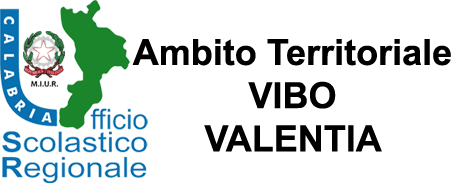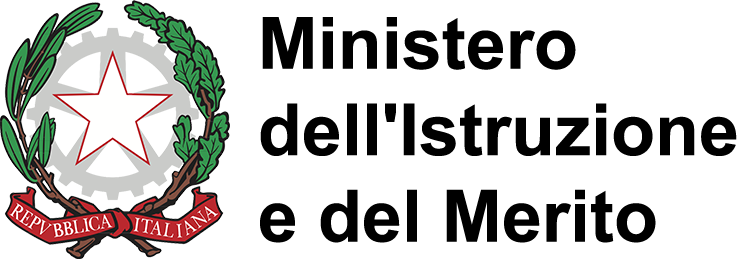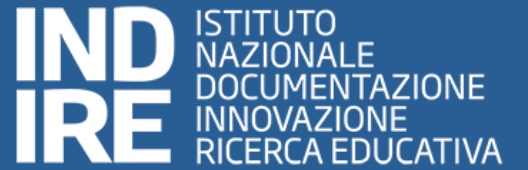Perché la norma che ha introdotto in Italia l’amministrazione di sostegno, pensata per favorire l’emancipazione e l’autodeterminazione delle persone in situazioni di fragilità, si è trasformata in molti casi in una violazione dei diritti umani? Lo chiede Stefania Delendati a Maria Giulia Bernardini, docente dell’Università di Ferrara, secondo la quale «il problema è innanzitutto il fatto che la visione “incapacitante”, ancorata al paradigma medico-individualista della disabilità, è ancora molto diffusa»
Continuiamo ad approfondire il tema dell’amministrazione di sostegno, ospitando questa volta l’analisi e i commenti della professoressa Maria Giulia Bernardini, docente di Teorie dei Diritti Umani e Diritto e Genere all’Università di Ferrara. A lei che si occupa in particolare dei temi della capacità legale, della vulnerabilità, dell’intersezionalità, degli stereotipi e del diritto all’abitare, abbiamo chiesto la genesi di quella legge – la Legge 6 del 2004, com’è noto – pensata per favorire l’emancipazione e l’autodeterminazione delle persone in situazioni di fragilità che però in numerosi casi si è trasformata in una violazione dei diritti umani.
Ebbene, per Bernardini «il problema è innanzitutto culturale: la visione “incapacitante”, ancorata al paradigma medico-individualista della disabilità, è ancora molto diffusa». Nelle stesse Facoltà di Giurisprudenza, le studentesse e gli studenti che svolgeranno professioni legate all’applicazione dell’amministrazione di sostegno, raramente incontrano il tema della disabilità e ancor più di rado vengono a conoscenza della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità.
La docente ci spiega il concetto di “capacità legale universale” e come si sono regolati gli altri Paesi europei ed extraeuropei in merito agli istituti di tutela. Riguardo poi alle modifiche necessarie alla normativa per limitare le vicende in cui la volontà della persona rimane inascoltata e si verificano atti di sostituzione e sovente veri e propri abusi di potere, suggerisce che «si potrebbe ad esempio intervenire sui poteri dell’amministratore, prevedendo la sostituzione come extrema ratio (e quindi imponendo anche un onere di motivazione quando vi si ricorra); sulla gratuità dell’incarico, in modo da recuperare il senso di questo istituto, che dovrebbe mantenere ferma la centralità della persona; e ancora, sulla pluralità di amministratori nominabili, in modo tale da ridurre il rischio di abuso; infine, sui controlli esercitabili dal giudice, nonché sulla scelta dell’amministratore da parte del beneficiario». «Va ripensato l’intero sistema di supporto – conclude – e sotto questo punto di vista, che il cambiamento spaventi (e quindi provochi resistenze) è comprensibile, chiaramente, però, la paura non può essere una ragione valida per non restituire alle persone con disabilità i diritti che finora sono stati loro negati».
Prima dell’introduzione della Legge 6 del 2004, come ci si regolava quando una persona in condizione di fragilità aveva bisogno di essere tutelata mantenendo il proprio diritto di decidere in libertà per sé e per la sua vita?
«La sua è una domanda molto interessante, perché presuppone che ci si ponesse il problema di rispettare il diritto della persona di decidere per sé e per la sua vita. In realtà, si può dire che questo tema – e, con esso, la centralità della persona – sia stato preso pienamente in considerazione solo con l’introduzione dell’amministrazione di sostegno, dunque nel 2004. In origine, infatti, il Codice Civile (dove all’articolo 404 e seguenti troviamo disciplinate quelle che sono definite come “misure di protezione”) contemplava unicamente due strumenti: l’interdizione e l’inabilitazione. Queste misure, però, non avevano – e non hanno, dato che non sono state ancora abrogate – lo scopo di proteggere la persona e di valorizzare la sua volontà, ma il suo patrimonio, evitando il verificarsi di danni. Ad esempio, nel caso dell’interdizione (che è considerata l’antitesi dell’amministrazione di sostegno), in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, si inizia il procedimento che porta al relativo provvedimento del giudice. L’effetto di questo provvedimento è la perdita della capacità d’agire del beneficiario, che non può compiere né atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (dove è possibile l’intervento del tutore), né atti personalissimi, come sposarsi o effettuare una donazione (in questo caso, è esclusa anche la possibilità che gli atti siano posti in essere dal tutore). C’è da dire che, in relazione all’interdizione, negli ultimi anni i giudici spesso hanno cercato di forzarne le maglie, troppo rigide. In questo modo, però, le soluzioni valgono caso per caso e non assumono carattere generale.
In merito all’inabilitazione, che comunque è ormai caduta in desuetudine, l’istituto ha presupposti che non possono essere più condivisi, come la circostanza che l’essere persone sorde o cieche legittimi il ricorso all’istituto, e dunque la limitazione della capacità d’agire».
Questo, dunque, è quanto accadeva prima. Poi, però, la Legge 6/04 ha evidenziato non poche difficoltà di applicazione, chiaroscuri nei quali si nascondono situazioni di abuso, sostituzione della volontà della persona, anziché accompagnamento e sostegno. Cosa si potrebbe fare, quindi, per migliorare lo strumento dell’amministrazione di sostegno che quella norma ci mette a disposizione?
«Il problema è innanzitutto culturale: la visione “incapacitante”, ancorata al paradigma medico-individualista della disabilità, è ancora molto diffusa. Ad esempio, se resto all’àmbito con il quale sono più direttamente in contatto, le studentesse e gli studenti di giurisprudenza – che svolgeranno alcune delle professioni di rilievo in relazione all’applicazione dell’amministrazione di sostegno – incontrano raramente il tema “disabilità” nel corso dei loro studi, e ancor più raramente vengono a conoscenza dell’esistenza della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità e della “rivoluzione” che essa ha portato, anche in relazione al riconoscimento dei diritti e al loro esercizio. La presenza di esempi virtuosi, in controtendenza rispetto a questo quadro allarmante, non può fare perdere di vista un problema che ha ancora carattere sistematico. Se non cambia la cultura e non si acquista consapevolezza in merito al cambiamento di paradigma introdotto dalla Convenzione ONU, che impone di partire dalla presunzione di capacità della persona con disabilità, ogni modifica normativa rischia di restare unicamente sulla carta.
Premesso questo, sembra che sia giunto il momento di apportare alcune modifiche normative anche all’istituto dell’amministrazione di sostegno. Si potrebbe ad esempio intervenire sui poteri dell’amministratore, prevedendo la sostituzione come extrema ratio (e quindi imponendo anche un onere di motivazione quando vi si ricorra); sulla gratuità dell’incarico, in modo da recuperare il senso di questo istituto, che dovrebbe mantenere ferma la centralità della persona; sulla pluralità di amministratori nominabili, in modo tale da ridurre il rischio di abuso; sui controlli esercitabili dal giudice; sulla scelta dell’amministratore da parte del beneficiario».
In un’ottica di miglioramento e modifica dell’attuale normativa, come ci può venire in aiuto il diritto internazionale?
«Il punto di riferimento indiscusso è l’articolo 12 della citata Convenzione ONU, che disciplina la capacità legale universale. Dato che l’Italia ha ratificato la Convenzione [Legge 18/09, N.d.R.], che “entra” nel nostro ordinamento in una posizione superiore rispetto a quella della legge italiana, sussiste l’obbligo (finora disatteso) di modificare il quadro legislativo in modo da renderlo conforme rispetto a quanto stabilito nella Convenzione. L’articolo 12 fornisce, al riguardo, indicazioni incontrovertibili: è necessario partire dal presupposto che le persone con disabilità siano capaci e le misure adottate devono consentire alla persona l’esercizio della propria capacità d’agire. Al paragrafo 4, lo stesso articolo 12 individua anche alcuni elementi funzionali a rendere le misure in questione (che definirei “di supporto”, anziché “di protezione”, per sottolineare come siamo radicalmente lontani da una prospettiva paternalista) in linea con la Convenzione, come il rispetto della volontà e le preferenze della persona, la temporaneità, il controllo periodico, la proporzionalità.
Un altro strumento da tenere in considerazione è la Convenzione dell’Aia del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti incapaci, ma con due avvertenze: in primo luogo, questo strumento non è stato ratificato dall’Italia, quindi non ha vigore nel nostro ordinamento. Inoltre, già dalla scelta lessicale nel titolo si capisce come l’impostazione non sia pienamente in linea con il dettato della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, che continua ad essere il “faro”. Proprio per questo, attualmente, è aperta la procedura relativa all’adozione di un regolamento dell’Unione Europea (che ha ratificato la Convenzione ONU nel 2010), relativo alle misure e alla cooperazione in materia di protezione degli adulti. Anche se chiaramente non si tratta di uno strumento di diritto internazionale, credo che valga la pena seguire gli sviluppi, per l’impatto che un tale regolamento può avere anche all’interno dell’ordinamento italiano».
Restando alla Convenzione ONU e alla cornice da essa disegnata, quali effetti normativi si sono avuti nei Paesi europei ed extraeuropei in merito agli istituti di tutela? Quali norme sono state emanate e quali, a suo parere, sono le più apprezzabili?
«Tra i primi Paesi a modificare il proprio quadro giuridico nella direzione richiesta dal Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, figura la Costa Rica, che ha proceduto in questa direzione nel 2016. Ci sono poi riforme più recenti, come quelle che hanno interessato i Paesi Latinoamericani (il Perù nel 2018, la Colombia nel 2019, l’Argentina nel 2022). Nell’Unione europea, la Bulgaria si è attivata nel 2019, la Spagna e l’Irlanda nel 2022, la Germania nel 2023.
Le riforme, per quanto diverse tra loro, partono da alcuni presupposti comuni, riconducibili appunto all’articolo 12 della Convenzione ONU: eguale riconoscimento di fronte alla legge, creazione di sistemi di supporto/sostegno al processo decisionale, e modifiche (in senso restrittivo) alla possibilità di dichiarare l’incapacità assoluta dell’individuo. In nessun caso, però, si è abolita completamente la possibilità di procedere alla sostituzione del beneficiario della misura, anche se questa ipotesi è prevista come extrema ratio, e dunque ha carattere residuale.
L’Irlanda è forse lo Stato che può essere considerato più all’avanguardia. Sul piano dei princìpi, ha riconosciuto il diritto di autodeterminazione delle persone con disabilità e accolto il principio del supporto. Ha individuato anche alcuni processi decisionali assistiti, ad intensità crescente, che trovano applicazione dopo l’effettuazione di un test funzionale (che può essere considerato compatibile con la Convenzione ONU, se non è applicato in modo discriminatorio). Ha inoltre previsto l’istituzione di un nuovo servizio pubblico di supporto, con compiti informativi, di regolamentazione e registrazione degli accordi di supporto decisionale, di supervisione e di monitoraggio. Infine, ha stabilito che debba sempre essere rispettata la capacità di scelta delle persone che si trovano all’interno delle strutture residenziali, e che le misure eventualmente adottate debbano rispettare la giurisprudenza del Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità».
Forse a questo punto è il caso di spiegare ancor meglio il concetto di “capacità legale universale” e come esso si attui in merito ai diritti delle persone con disabilità.
«La “capacità legale universale”, prevista, come ampiamente detto in precedenza, dall’articolo 12 della Convenzione ONU, è la chiave di volta della Convenzione stessa, perché costituisce la base dell’eguale riconoscimento della soggettività e dei diritti umani delle persone con disabilità.
La formulazione di questo articolo è un po’ complessa ed è caratterizzata da alcuni aspetti tecnici, come la distinzione tra la capacità giuridica e quella di agire. Provando a sintetizzare, potremmo dire che il concetto di capacità legale universale si muove su diversi piani. In primo luogo, afferma a chiare lettere che la condizione di disabilità non può mai costituire una valida ragione per discriminare – in via diretta o indiretta – qualcuno né in relazione all’eguale riconoscimento della sua personalità giuridica (ossia come soggetto di diritto), né per quanto riguarda la titolarità della capacità legale e il suo esercizio. Insomma, non è ammessa nessuna presunzione relativa al fatto che, per il solo essere disabile, una persona non debba godere degli stessi diritti riconosciuti agli altri individui. Non è nemmeno possibile presumere che una persona con disabilità non sia pienamente capace: le eventuali limitazioni alla capacità andranno decise in relazione al caso singolo, e dovranno essere adeguatamente motivate, perché l’obiettivo è quello di conservare la più ampia capacità decisionale in capo alla persona. Certo, oggi nessuno immaginerebbe di affermare che le persone con disabilità non siano soggetti di diritto (ma la storia ci racconta altro, quindi riaffermarlo all’interno di una Convenzione che tutela i diritti umani non è superfluo). Al contrario, la capacità legale delle persone con disabilità è messa in discussione quasi quotidianamente.
In secondo luogo, in base al paragrafo 3 dell’articolo 12, gli Stati che hanno ratificato la Convenzione sono tenuti a prendere tutte le misure che garantiscano alle persone con disabilità il pieno supporto nell’esercizio della propria capacità. Si tratta di accorgimenti di varia natura, formali o informali, che consentano alla persona di autodeterminarsi e di esercitare un controllo reale sulla propria vita. L’amministrazione di sostegno può essere ricompresa all’interno di questi strumenti di supporto: alla luce di quanto ho provato a ricostruire finora, è evidente che il compito dell’amministratore di sostegno dovrà essere quello di accompagnare (e non di sostituirsi) alla persona beneficiaria, e che il suo operato dovrà sempre essere diretto a valorizzare al maggior grado possibile la capacità di quest’ultima. Per questo è improprio considerarlo uno strumento di incapacitazione, come a volte si legge: grazie all’articolo 12 della Convenzione si cambia prospettiva, e il punto non è “incapacitare”, ossia limitare la capacità della persona, ma affiancare quest’ultima, assistendola nell’esercizio della sua capacità nel modo meno invasivo possibile. E infatti, come ho ricordato prima, il paragrafo 4 dell’articolo 12 fissa alcuni requisiti delle misure di supporto, sempre al fine di salvaguardare la persona, i suoi diritti e la sua volontà».
Nel saggio La capacità legale universale come requisito indefettibile della libertà. Notazioni teoriche in un’ottica di riforma lei afferma che «gli istituti giuridici che privino un individuo con disabilità dei propri diritti in ragione della sua asserita incapacità non possono in alcun modo essere considerati conformi al dettato normativo della Convenzione. Tra questi, devono essere inclusi gli istituti che negano ab origine, o comunque consentono, la completa privazione della capacità legale e, su tale base, quella della libertà personale o di scelta, a causa della sola presenza di un deficit, reale o percepito”. Riguardo alle persone con disabilità psicosociali, intellettive o cognitive, quali nozioni innovative introduce la Convenzione ONU?
«Come ho già ricordato, in base alla Convenzione ONU la condizione di disabilità non può essere una valida ragione per discriminare una persona. Questo richiede il superamento dell’idea che la disabilità determini l’incapacità dell’individuo e, al contrario, di considerare la disabilità come una delle (molte) specificità della persona, con un approccio che può essere definito “neutro”.
Tra le conseguenze più rilevanti di questa prospettiva c’è la necessità di tenere distinte la capacità legale (quella che consente di muoversi tra le maglie del diritto, ad esempio concludendo un contratto o effettuando scelte relative alla propria vita personale) e quella mentale, su cui ha insistito molto il Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, in particolare nel General Comment n. 1. Ciò significa che ogni negazione della capacità legale stabilita in base all’asserita assenza di capacità mentale è contraria all’articolo 12 della Convenzione, così come lo è ogni diagnosi di incapacità che sia basata sullo status, sulla valutazione relativa alle conseguenze delle scelte effettuate, o di tipo funzionale.
Questa circostanza assume particolare rilievo per le persone con disabilità psicosociali, intellettive o cognitive, in relazione alle quali lo stigma associato alla “capacità mentale” è sempre stato particolarmente forte. Ai sensi della Convenzione ONU, non è ammesso in alcun modo che se ne presuma l’incapacità: anche nel loro caso, infatti, bisognerà partire da una presunzione di capacità e supportarle nell’esercizio della propria capacità legale, facendo riferimento ai criteri individuati dall’articolo 12».
Nel medesimo saggio lei parla di “atteggiamento difensivo” da parte degli Stati nell’implementazione dell’articolo 12 all’interno delle proprie normative. Per quali ragioni si è attuato questo “atteggiamento difensivo”? E riguardo all’Italia, quali sono le maggiori resistenze che si incontrano?
«L’atteggiamento difensivo di alcuni Stati si è tradotto innanzitutto nell’apposizione di riserve all’articolo 12, il che consente loro di non darvi attuazione, nonostante abbiano ratificato la Convenzione nel suo complesso; a questo riguardo, bisogna però notare che l’Italia non ha apposto riserve, dunque è vincolata all’attuazione di tutti gli articoli della Convenzione.
In altri casi, gli Stati hanno adottato dichiarazioni interpretative in relazione all’ammissibilità della sostituzione, per limitare l’impatto dell’articolo 12, o non hanno abrogato gli istituti in diretto contrasto con la Convenzione (nell’ordinamento italiano, l’interdizione e l’inabilitazione sono ancora vigenti) e hanno scelto una linea più “morbida”, riformando la disciplina legislativa solo parzialmente.
Credo che le ragioni per le quali si preferisce un approccio più “moderato” nell’applicazione della Convenzione, e in particolare dell’articolo 12, siano varie e che cambino nei diversi contesti politici e istituzionali. Di certo, si sconta anche un problema culturale: l’articolo 12, infatti, impone un cambio di prospettiva radicale e, fino a non molto tempo fa, impensabile. Oggi abbiamo fatto certamente molti passi in avanti nella restituzione dei diritti immotivatamente negati alle persone con disabilità, ma il cammino è ancora lungo, e anche il relativo lavoro culturale.
Per quanto riguarda l’Italia, nonostante la Convenzione sia entrata in vigore ormai da sedici anni, i princìpi di essa sono ancora in gran parte non conosciuti non solo nella società, ma anche tra gli “addetti ai lavori”, e questo fa sì che manchino molti strumenti per darvi piena attuazione, perché le questioni che stanno emergendo sono nuove. Prima si dava per scontata l’incapacità della persona con disabilità e si riteneva che questo stato di cose non potesse essere cambiato. Ora si comprende che quello che era considerato naturale in realtà è l’esito di una discriminazione sistemica: vediamo quotidianamente quanto sia difficile portare avanti moltissime lotte, compresa quella diretta a garantire la vita indipendente e la deistituzionalizzazione, proprio perché il modello medico-individualista della disabilità è ancora diffuso. Dal canto suo, la capacità legale universale impone di abbandonare il sistema binario capacità/incapacità, e quindi mina le fondamenta stesse del diritto per come lo conosciamo, aprendo numerosi profili di incertezza, anche alla luce del fatto che va ripensato l’intero sistema di supporto. Sotto questo punto di vista, che il cambiamento spaventi (e quindi provochi resistenze) è comprensibile. Chiaramente, però, la paura non può essere una ragione valida per non restituire alle persone con disabilità i diritti che finora sono stati loro negati».
*Maria Giulia Bernardini è docente di Teorie dei Diritti Umani e Diritto e Genere all’Università di Ferrara; Stefania Delendati è la direttrice responsabile di Superando.
L'articolo La visione “incapacitante” nell’applicazione dell’amministrazione di sostegno proviene da Superando.